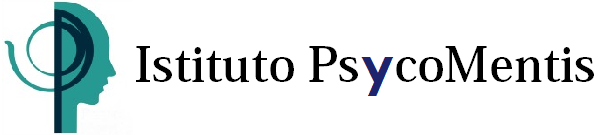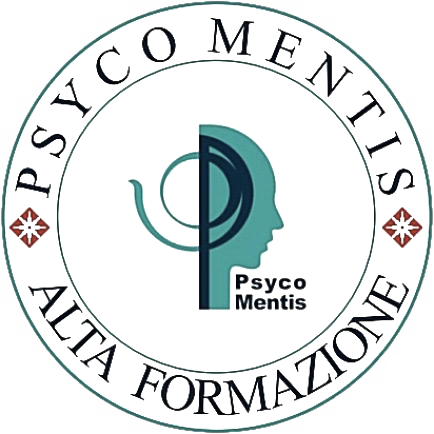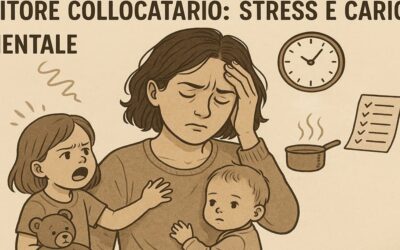Il ruolo del padre ha subito, negli ultimi decenni, una profonda trasformazione. Il ruolo del padre da figura tradizionalmente associata all’autorità e al sostegno economico della famiglia sta progressivamente assumendo un ruolo sempre più relazionale, affettivo e partecipativo nella vita dei figli.
Questa evoluzione è particolarmente significativa nel contesto delle separazioni e delle nuove configurazioni familiari, dove il ruolo paterno diventa cruciale per garantire la continuità affettiva, educativa ed evolutiva del minore.
Dal padre distante al padre coinvolto
Nel modello patriarcale classico, il padre era percepito come figura normativa, distante, incaricata di impartire regole e garantire la disciplina. L’accudimento e la relazione affettiva con i figli erano invece prerogativa quasi esclusiva della madre.
Con l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, i cambiamenti culturali e le riforme del diritto di famiglia (come la legge 151/1975 e la 54/2006), si è progressivamente affermato il concetto di paternità condivisa, fondata su responsabilità equivalenti e sul riconoscimento del padre come figura affettiva ed educativa, non solo funzionale.
La funzione paterna: identità, autonomia e limite
Secondo la letteratura psicologica e psicoanalitica, la funzione paterna è strutturante per lo sviluppo del bambino.
Essa non si limita alla presenza fisica, ma rappresenta il ponte simbolico tra il nucleo familiare e il mondo esterno, favorendo:
- il processo di separazione-individuazione del figlio dalla madre;
- la costruzione dell’identità e dell’autostima;
- l’interiorizzazione del senso del limite e delle regole sociali;
- lo sviluppo di relazioni paritarie e rispettose.
La presenza paterna “sufficientemente buona” – come direbbe Winnicott – rappresenta un fattore protettivo nello sviluppo emotivo del minore, contribuendo a consolidare un attaccamento sicuro e differenziato.
Il padre nelle separazioni: presenza, ostacoli e valorizzazione
Nel contesto delle separazioni e dei divorzi, il padre rischia ancora oggi, nonostante l’affidamento condiviso sia il principio generale, di essere marginalizzato. Come documentato da molte ricerche, la residenza prevalente presso la madre, le difficoltà relazionali tra ex partner e la persistenza di stereotipi culturali, possono ostacolare l’effettiva esercitazione del ruolo paterno.
In tali situazioni, è fondamentale promuovere:
- la co-genitorialità, intesa come collaborazione responsabile tra genitori separati;
- la mediazione familiare per superare i conflitti e ristabilire un dialogo centrato sul benessere del figlio;
- l’utilizzo di strumenti come la coordinazione genitoriale per garantire il rispetto delle responsabilità condivise e il diritto del minore alla bigenitorialità reale.
Padri e cura: un cambiamento irreversibile
Oggi i padri sono sempre più presenti fin dalla nascita del figlio: partecipano al parto, ai colloqui scolastici, si occupano della cura quotidiana, costruiscono relazioni affettive profonde, basate sulla reciprocità e sull’empatia. Non si tratta di una “sostituzione” del ruolo materno, ma di una ridefinizione dei ruoli genitoriali in chiave paritaria.
Questo cambiamento, tuttavia, richiede un adeguamento culturale e istituzionale: leggi più eque, tribunali sensibili al valore della relazione padre-figlio, servizi territoriali capaci di accogliere e sostenere la nuova paternità, e una società che riconosca e valorizzi la presenza del padre non solo come “opzionale”, ma come necessaria.
La figura paterna, lungi dall’essere un ruolo accessorio, rappresenta un pilastro educativo, affettivo e identitario per lo sviluppo dei figli. Riconoscerne il valore, soprattutto nelle situazioni familiari complesse, significa garantire ai bambini e ai ragazzi una crescita equilibrata, ricca di riferimenti e significati.
Nel tempo della “società liquida”, in cui i legami sono fragili e i ruoli sfumati, la paternità consapevole e presente è uno dei punti fermi su cui costruire relazioni familiari autentiche e generative.
Leggi anche: